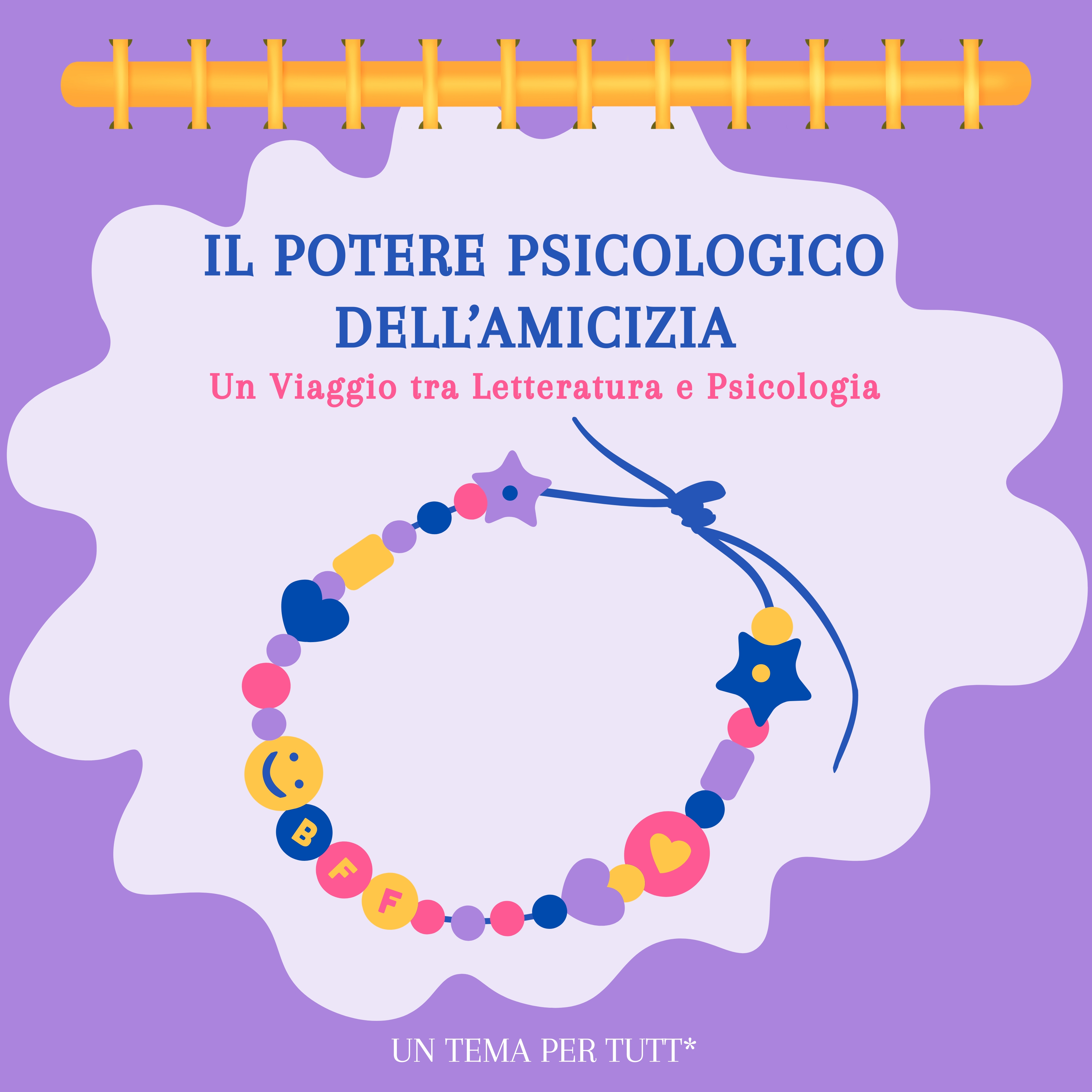
07/28/2025
IL POTERE PSICOLOGICO DELL'AMICIZIA. Un Viaggio tra Letteratura e Psicologia
Michele ClementeAlcune tra le più importanti opere enciclopediche esistenti descrivono l’amicizia come un sentimento d’affetto nella relazione tra gli individui, altre come una relazione sociale, quasi un’istituzione, a dimostrazione del fatto che si tratta di una questione complessa e multiforme. Senza dubbio organizza sistemi relazionali e sociali e ha un grande impatto nell’evoluzione della società ma altrettanto importante è la sua influenza sull’individuo: l’amicizia è una delle esperienze più profonde e complesse dell’esistenza umana, è un legame affettivo ed intimo che agisce sullo sviluppo dell’identità, sulla stabilità emotiva e sul senso di appartenenza. Ha attraversato le epoche, lasciando tracce indelebili nella filosofia, nella religione, nella letteratura e nella psicologia.
Nei poemi omerici emergono con forza immagini archetipiche di amicizia che hanno risonanza psicologica. La morte di Patroclo segna una svolta psicologica nell’animo di Achille. Inizialmente invincibile e distaccato, Achille è trafitto dalla perdita dell’amico, prima ancora che dalla lancia di Paride, una sofferenza che va oltre il dolore fisico. Achille perde il controllo, la sua collera diventa distruttiva e vendicativa. Torna a combattere andando incontro alla profezia della sua morte in giovane età soprassedendo, così, anche all’istinto di autoconservazione.
Diversamente, nell’Odissea, il rapporto tra Ulisse e i suoi compagni riflette una forma di amicizia più matura. Non si tratta di un legame simbiotico, come era stato per Achille e Patroclo, ma cooperativo e di condivisione. Ulisse non si definisce attraverso i suoi compagni di viaggio si affida a loro e si adopera per aiutarli, soffre per la loro perdita ma non vive una crisi personale o identitaria. Il suo scopo resta personale ed immutato. Raggiungere Itaca.
Anche in “Siddharta” l’amicizia tra il protagonista e Govinda è centrale. Inizialmente si tratta di un legame ai limiti della simbiosi che, più avanti, lascia spazio a scelte individuali che ne provocano un distanziamento con un piacevole ritrovarsi nella parte finale del romanzo, come ad indicare l’evoluzione fisiologica di un legame che resta importante punto di riferimento, ma legittima l’esistenza di bisogni individuali.
Nel corso della storia, la filosofia ha offerto molte interpretazioni dell’amicizia. Aristotele ne distingue due tipi: quella basata sull’utile e il piacere e quella che poggia sulla virtù, quest’ultima la più autentica e duratura. Nel Medioevo, l’amico è spesso compagno di battaglie o di viaggio, nel senso spirituale del termine; nel Rinascimento diventa simbolo di fiducia e apertura totale.
L’individualismo dell’epoca contemporanea ci spinge a considerare l’amicizia come un riflesso, o forse uno strumento utile alla crescita individuale e allo sviluppo dell’identità personale.
Come Siddharta e Govinda, anche noi attraversiamo un ciclo evolutivo di amicizie: vicinanze e distacchi, conflitti e riconciliazioni, perdite e nuovi incontri. Tale ciclo evolutivo appare intrecciarsi, o forse proprio originarsi, dal ciclo evolutivo individuale: dal susseguirsi di conflitti e crescite, scelte e indecisioni che contraddistinguono la vita di ognuno.
Ogni tentativo di riordinare ciò che accade nei legami amicali e intercettare come questi aiutino l’individuo a crescere e formarsi, può apparire semplicistico ma riprendendo i diversi stadi del ciclo evolutivo si può avere un’idea di come l’amicizia, in ogni momento della nostra vita, assuma una funzione importantissima.
Durante l’infanzia le relazioni amicali sono fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva. Nei giochi, nei piccoli litigi, nella condivisione, i bambini imparano a riconoscere e regolare le proprie emozioni. La presenza di un amico offre una prima forma di alleanza esterna al nucleo familiare ma lo espone anche alla frustrazione di alcuni bisogni quando deve confrontarsi con quelli dell’altro. I legami amicali in questa fase contribuiscono alla costruzione dell’autonomia emotiva e l’inizio di una strutturazione di un sistema di sicurezza.
Durante l’adolescenza, l’amicizia diventa un rifugio e un terreno di esplorazione. In un momento in cui l’individuo si confronta con i cambiamenti fisici, cognitivi e relazionali, l’amico è spesso lo specchio privilegiato del proprio tumulto interiore. In questa fase, l’amicizia diventa più selettiva, più intensa, e in alcuni casi anche esclusiva. È qui che si sperimenta l’intimità emotiva, il segreto condiviso, la lealtà, il conflitto e la riconciliazione, un senso di sicurezza fuori dalle mura domestiche: prove generali dell’amore adulto.
Nella maturità, l’amicizia si consolida come spazio di comprensione reciproca, soprattutto in un mondo in cui le pressioni lavorative, familiari e sociali possono isolare. L’amico diventa colui che aiuta a rileggere le esperienze della vita, a mantenere il contatto con se stessi. Psicologicamente, le amicizie adulte rappresentano una delle principali fonti di resilienza.
Nella terza età, le amicizie resistenti diventano ancora più preziose. In un’epoca della vita segnata da perdite – di ruolo, di autonomia, di persone care – l’amico è colui che dà continuità alla narrazione della propria identità. È memoria condivisa, ma anche presente emotivo. Mantenere relazioni amicali attive è uno dei principali fattori protettivi contro il decadimento cognitivo e la depressione.
In conclusione sembra possibile affermare che l’amicizia sia un viaggio potente dentro noi stessi e non solo un incontro con l’altro: ci mostra i limiti, ci regala risorse, ci fa sentire emozioni che vanno dal calore dell’appartenenza al gelo della perdita. I legami che costruiamo raccontano di noi, delle nostre battaglie invisibili, delle ferite mai del tutto guarite e dei passi di crescita ancora da compiere.
Non è solo un sostegno nei momenti critici, ma uno specchio fedele. Talvolta in terapia viene usata cosí, come riflesso delle nostre fatiche e dei nostri tentennamenti o come base sicura su cui poter contare nel continuo processo trasformativo che è l’esistenza.
Aristotele, Etica Nicomachea, a cura di G. Reale, Bompiani, Milano, 2006.
Hesse H. 1985, Siddharta. Trad. Massimo Mila. Adelphi
Ihle A, Oris M, Baeriswyl M, Kliegel M. Int Psychogeriatr. 2018 Jun 1:1-6 Il rapporto tra amici intimi e prestazioni cognitive in età avanzata: il ruolo di mediazione delle attività ricreative
M. C. Gislon 2005, Manuale di psicoterapia psicoanalitica breve. Dialogo Edizioni
M.C Gislon, V.Franchi 2017, La psicoterapia Breve in adolescenza. Mimesis Edizioni
scarica l'articolo completo






