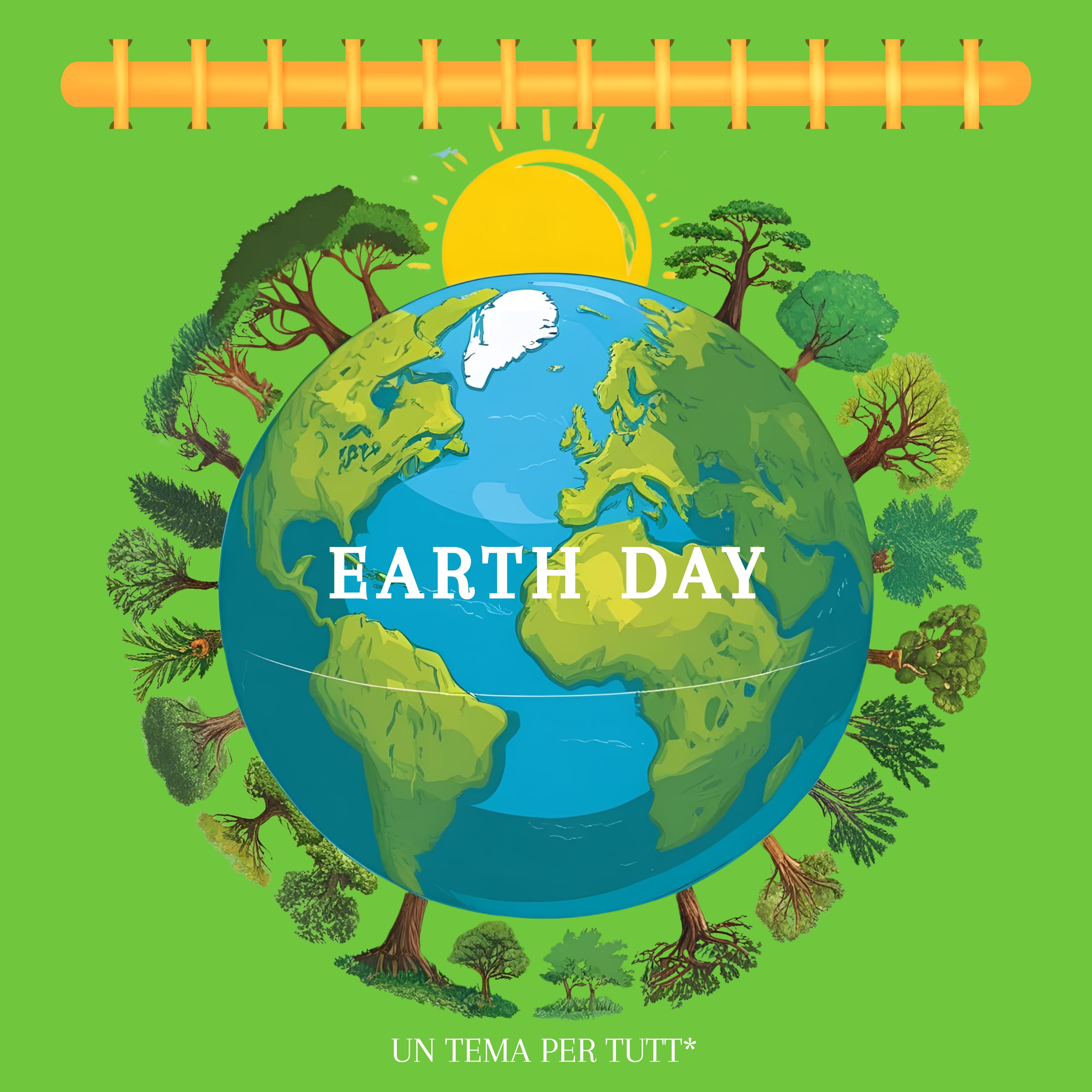
04/22/2025
LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
Nicoletta VurroL’Earth Day, o giornata mondiale della Terra, si celebra il 22 aprile di ogni anno dal 1970 per sottolineare la necessità di tutelare le risorse naturali della grande casa che tutti gli abitanti del pianeta condividono - la Terra - ma anche per promuovere una corretta educazione ambientale.
L’idea che una giornata dedicata alla Terra fosse necessaria venne presa in considerazione agli inizi degli anni Sessanta del Novecento, ma divenne di importanza politica solo nel 1969, grazie alla voce di un senatore democratico del Wisconsin, Gaylord Nelson, a seguito di un disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di petrolio da un pozzo in California: “Tutte le persone, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno diritto a un ambiente sano, equilibrato e sostenibile”, ha affermato.
Fu così che il 22 aprile dell’anno successivo 20 milioni di cittadini americani si mobilitarono, riunendosi per una causa comune.
Non solo la giornata della Terra contribuì all’organizzazione di iniziative ambientali a livello mondiale, ma aprì anche la strada al Vertice delle Nazioni Unite del 1992 a Rio de Janeiro, la prima conferenza mondiale a tema ambientale che ha visto partecipare i principali capi di stato. Inoltre, parallelamente all’Earth Day, è nato quello che oggi conosciamo come movimento ambientalista moderno.
Bisognerà aspettare il 2000, grazie alla diffusione di internet, per vedere l’Earth Day diffondersi a livello globale, con celebrazioni in 193 diversi paesi del mondo.
Perchè è importante l’Earth Day?
Con la consapevolezza sempre crescente e la chiara convergenza della comunità scientifica circa le cause antropiche dei cambiamenti climatici l’attenzione per l’ambiente è diventata sempre più una tematica sentita, soprattutto dalle giovani generazioni.
In parallelo si è assistito, in ambito psicologico, a un crescente interesse per l’ecopsicologia, una disciplina che si pone come macro-obiettivo quello di migliorare il benessere delle persone e del pianeta, a partire da una visione “ecocentrica” e non più “egocentrica”, capace cioè “di includere insieme all’essere umano tutto il creato, coerentemente con il cambiamento di paradigma in atto in campo scientifico, verso una visione sistemica della realtà” (Danon, 2020).
Se quindi la psicologia si è sempre concentrata principalmente sull’ambiente interno dell’individuo e l’ecologia sull’ambiente esterno, l’idea dell’ecopsicologia è quella di unire queste discipline e integrarle: l’essere umano non può più essere studiato e compreso al di fuori del pianeta che abita e al contempo l’ambiente che ci circonda non può essere considerato senza considerare l’impatto che l’uomo ha su di esso, e sulla necessità di responsabilizzare l’individuo senza colpevolizzarlo.
Uno studio (Bratman et al., 2019) ha messo in luce come si registri un aumento di disagio psichico e depressione proprio nei paesi in cui vi sono grandi centri urbani e dove il contatto con la natura è ridotto. Uno studio giapponese del 2020 (Soga et al., 2020) ha messo in luce che durante il periodo del COVID-19 la possibilità di avere anche solo una finestra da cui osservare la natura era associata a migliore autostima, migliore soddisfazione e felicità soggettiva, nonché a una diminuzione di depressione, ansia e solitudine. In generale, in letteratura si riscontra un ampio consenso circa l’associazione tra esperienze in natura e miglior benessere psicologico e, al contempo, diminuzione dei fattori di rischio per lo sviluppo di disagio psichico (Orban et al, 2017; Jennings e Bamkole, 2019, Bratman et al., 2015; Stevenson et al., 2018; Dadvand, 2015; Roe et al., 2013; Grigsby et al., 2015; Roe et al., 2016; Gascon et al., 2015; De Vries, 206; Cohen-Cline, 2015; Beyer et al., 2014; Astell-Burt, 2014).
A fronte di tali dati, l’idea dell’ecopsicologia è quella di risvegliare ciò che Theodore Roszak, storico della cultura e docente universitario nonché anche autore del primo testo ufficiale di eco psicologia, chiama “inconscio ecologico”. Secondo l’autore si tratta di un inconscio collettivo condiviso tra tutte le specie; quando esso è represso o inconsapevole, rende possibile il danneggiamento della natura senza che esso venga percepito come problematico dall’essere umano. In terapia, quindi, l’obiettivo diventa riportare a galla l’inconscio ecologico, risvegliando il senso di reciprocità con la natura insito nell’uomo e permettendogli di tornare a provare un senso di responsabilità e di amorevolezza nei confronti della propria casa. Citando Danon (2020): “Tra noi e il pianeta c’è la stessa relazione che c’è tra una foglia e l’albero di cui fa parte, tra un’onda e l’oceano sulla cui superficie corre, tra una cellula e il corpo intero a cui appartiene”.
In questa prospettiva si sente sempre più parlare di ecoemozioni: emozioni specificatamente legate alla natura e all’ecosistema e che riflettono i cambiamenti cui l’ambiente è soggetto e l’impatto che questi cambiamenti hanno sugli individui. Così, negli ultimi anni, abbiamo assistito sempre più alla diffusione di termini come “eco-ansia”, “solastalgia”, “terrafurie”, che tentano di spiegare stati d’animo complessi e specifici di chi si trova a contatto con una natura che non è più quella che conosceva o che non riconosce come quella “madre Terra” accogliente e sicura. D’altro canto, si sono diffusi anche termini che riflettono l’amore e l’attaccamento per la natura come “eutierria”, “sumbiofilia” ed “endemofilia”.
Come spesso accade, la comunità scientifica si è maggiormente concentrata sugli effetti delle ecoemozioni spiacevoli, soprattutto rispetto all’eco-ansia in merito alla quale è in atto un dibattito circa la sua natura più o meno patologica.
Un piccolo approfondimento sull’eco-ansia
L’eco-ansia è l’ansia legata alla crisi ecologica e al cambiamento climatico che può emergere sia come conseguenza di un problema ambientale direttamente sperimentato (come le recenti alluvioni in Emilia-Romagna) sia come una consapevolezza del cambiamento climatico che ci viene raccontato attraverso i media. La presenza della parola “ansia” suggerisce che si tratta di uno stato caratterizzato da ansia e preoccupazione sul futuro accompagnato da ruminazione e irritabilità che può sfociare anche in attacchi di panico e può associarsi a problemi nel sonno e nell’alimentazione (Clayton e Karazsia, 2020). Ad oggi l’eco-ansia viene considerata prevalentemente come una risposta adattiva ai problemi ambientali, soprattutto se la sua sperimentazione rientra all’interno di una “soglia” che consente l’attivazione dei cosiddetti “comportamenti pro-ambientali” ovvero tutta quella serie di atteggiamenti finalizzati alla cura e alla tutela dell’ambiente (dal semplice riciclare i rifiuti al fare attivismo). Quando la sperimentazione di questa emozione diventa cronica, è possibile sviluppare degli altri disturbi oppure la pre-esistenza di problemi di salute mentale può aggravare lo stato di eco-ansia (Pihkala, 2020; Cianconi e Yaniri, 2023).
Come la consapevolezza delle eco emozioni ci può aiutare a onorare l’Earth Day?
Pensare all’ambiente come la nostra casa e non solo come a una scenografia che fa da sfondo alle nostre vite può portarci in contatto con le nostre eco emozioni, magari facendoci scoprire un legame più profondo con l’ambiente di quello che immaginavamo: se pensiamo a un posto per noi caro, cosa ci viene in mente? È stato impattato dal cambiamento climatico? Come questo cambiamento ci fa sentire?
Avere maggiore consapevolezza delle nostre eco emozioni ci permette di comprendere quale direzione la nostra bussola interiore ci sta indicando. Questo potrebbe portarci a scegliere di iniziare, magari da oggi, di mettere in campo dei comportamenti pro ambientali che fanno bene a noi e all’ambiente: coltivare sul balcone un piccolo orto, inserire nei vasi fiori e piante amici delle api, fare la raccolta differenziata, usare la bicicletta o i nostri piedi come mezzo di trasporto, passare più tempo in natura per fare amicizia con quella parte di noi che forse abbiamo messo in secondo piano. Ogni comportamento che ci permette di (ri)cominciare a creare quel legame che abbiamo perduto col mondo naturale porterà con sé la sperimentazione di nuove (eco)emozioni che potranno farci conoscere qualcosa di più su di noi e della nostra relazione col Pianeta.
In un’ottica di integrazione, cara al nostro Istituto, diventa importante considerare il legame dell’essere umano con l’ambiente, per supportare e favorire il benessere dell’individuo a 360°, che avrà di riflesso anche un impatto positivo sul Pianeta.
Bibliografia
Astell-Burt T., Mitchell R., Hartig T. (2014) The association between green space and mental health vaies across the lifecourse. A longitudinal study. K. Epidemiol. Community Health. 68, 578-583.
Beyer K.M.M., Kaltenbach A., Szabo A., Bogar S., Nieto F.J., Malecki K.M. (2014) Exposure to neighborhood geen space and mental health: evidence from the Survey of the Health of Wisconsin. Int. J. Environ. Res. Public Health. 11, 3453-3472.
Bratman G.N., Daily G.C., Levy B.J., Gross J.J. (2015). The benefits of nature experience: improved affect and cognition. Landsc. Urban Plan. 138, 41-50.
Bratman G.N. et al. (2019) Nature and mental health: an ecosystem service perspective. Science Advances
Cianconi e Yaniri (2023) Cambiamento climatico e salute mentale. Dall’ecologia della mente alla mente ecologica. Raffaello Cortina Editore.
Clayton S., Karazsia B.T. (2020) Development and validation of a measure of climate change anxiety. Journ of Environ Psych. 69, 101434.
Cohen-Cline H., Turkheimer E., Duncan G.E. (2015) Access to green space, physical activity and mental health: A twin study. J. Epidemiol. Comunity Health. 69, 523-529.
Danon, M. (2020) Ecopsicologia. Edizioni Aboca.
Dadvand, P., Nieuwenhuijsen M. J., Esnaola M., FOrns, K., Basagana X., Alvarez-Pedrerol M., Rivas I., LOpes-Vicente M., De Castro Pascual M., Su J., Jerret M., Querol X., Sunyer J. (2015) Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 112, 7937-7942.
De Vries S., ten Have M., van Dorsselaer S., van Wezep M., Hermans T., de Graaf R. (2016) Local availability of green and blues pace and prevalence of common mental disorders in the Netherland. BJPsych. Open. 2, 366-372.
Gascon M., Triguero-Mas M., Martinez D., Dadvand P., Forns J., Plasencia A., Niuwenhuijsen M.J. (2015) Mental health benefits of long-term exposure to residential green and blue spaces: a systematic review. Int. J. Environ. Res. Public Health. 12, 4354-4379.
Grigsby-Troussaint D.S., Turi K.N., Krupa M., Williams N.J., Pandi-Perumal S.R., Jean-Louis G. (2015) Sleep insufficiency and the natural environment: results from the US Behavioral Risk Factor Surveillance System survey. Prev. Med. 78, 78-84.
Jennings V., Bamkole O. (2019) The relationship between social cohesion and urban green space: an avenue for health promotion. Int J. Environ. Res. Public Health. 16, 452.
Orban E., Sutcliffe R., Dragano N., Jockel K.H., Moebus S. (2017) Residential surrouding greenness, self-rated health and interrelations with aspects of neighborhood environment and social relations. J Urban Health 94, 158-169.
Pihkala P. (2020). Anxiety and ecological crisis: An analysis of eco-anxiety and climate anxiety. Sustainability. 12 (19), 7836.
Roe J., Thompson, C, Aspinall P., Brewer M. Duff E., Miller D., Mitchell R., Clow A. (2013) Green space and stress: evidence from cortisol measures in deprived urban communities. Int. J. Environ. Res. Public Health, 10, 4086-4103.
Roe J. (2016) Cities, green space, and mental well-being, Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science (Oxford Univ. Press, 2016).
Soga M. et al., (2020) A room with a green view: the importance of nearby nature for mental health during the COVID-19 pandemic. ESA Journal. 31, 2.
Stevenson M.P., Schilhab T., Bentsen P. (2018) Attention Restoration Theory II: a systematic review to clarify attention processes affected by exposure to natural environments. J. Toxicol. Environ. Health B Crit. Rev. 21, 227-268.
scarica l'articolo completo






